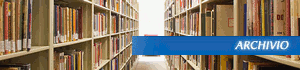Africa: investire sull’unità

Romano Prodi con, da sinistra, il sultano Bajan Ag Mahatou, dal Mali; Tchiffi Zie Jean Gervais, sovrano della tribù Grou della Costa D'Avorio; e Mwenda Bantu Munongo, re della tribù dei Bayke, dal Congo
Investire sull’unità. È la ricetta proposta da Romano Prodi in qualità di consulente delle Nazioni Unite per l’Africa. La chiave del cambiamento viene individuata in una crescente coesione continentale.
Intervista a Romano Prodi su Nigrizia di settembre 2010.
Dopo aver scelto di non partecipare alla teatrocrazia italiana, una volta spenti i riflettori sul suo governo, Romano Prodi ha voltato decisamente pagina nella sua vita professionale. L’ennesima rivoluzione: docente nelle università cinesi e americane e consulente dell’Onu per l’Africa. Un continente per il quale ha coltivato una passione mai camaleontica e che ha attraversato tutta la sua stagione pubblica. È forse l’unico “politico” italiano davvero ascoltato da molti leader africani e che ha tuttora un ruolo internazionale legato all’Africa. Le Nazioni Unite lo hanno messo a capo di un gruppo di esperti chiamato a riformare le missioni di pace nel continente. Lui, con la sua Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, ha rilanciato, portando lo scorso maggio a Bologna capi di stato e di governo dei 53 paesi dell’Unione africana, esperti di istituti internazionali, come la Banca mondiale, e rappresentanti di Cina, Usa e Unione europea. L’obiettivo era ridare valore all’integrazione tra i paesi africani. «Non solo da un punto di vista culturale. Ma politico», spiega Prodi, che bisserà l’appuntamento l’anno prossimo a Washington e nel 2012 ad Addis Abeba. «Non è mica una cosa bolognese».
Una premessa, presidente: in più di un’occasione lei ha sottolineato la scarsa riflessione in Italia su quanto è successo in questi decenni e sta accadendo oggi in Africa. Perché a lei, invece, appassionano così tanto, e da tanto tempo, le vicende africane?
È vero: in Italia non c’è sensibilità su questi temi. Siamo chiusi di fronte agli altri. La chiusura è la logica conseguenza della paura, del non volere immedesimarsi nei cambiamenti del mondo. È cominciata una nuova era: siamo in presenza di stravolgimenti radicali. Noi italiani pensiamo di non subirli. Il risultato, invece, è che non solo li stiamo subendo, ma anche che non siamo attori attivi di questi cambiamenti. La mia passione per l’Africa risale a molti anni fa, soprattutto durante il periodo di presidenza della Commissione europea. L’occasione per approfondirne ulteriormente la conoscenza mi è stata offerta dalla proposta delle Nazioni Unite di presiedere un ristretto gruppo di analisti sul peacekeeping, il cui compito è avanzare alcune proposte sulla sua riforma. Perché, anche in questo caso, l’Africa è un continente dimenticato. Nessun paese vuole prendersi la responsabilità, né politica né militare, di lavorare in quel continente.
Il segretario generale Ban Ki-moon le ha forse chiesto d’indagare sui fallimenti delle iniziative di peacekeeping dell’Onu in Africa?
Ban Ki-moon e i funzionari del Palazzo di Vetro conoscono molto bene l’elenco delle critiche che vengono loro mosse e dei fallimenti delle missioni. In realtà, il segretario ci ha posto il problema di come può l’Africa aiutare sé stessa. Un compito immane. Perché siamo di fronte a un continente molto diviso. Nessun paese, neppure l’Egitto o la Nigeria, ha la forza politica, l’economia di scala, la dimensione, la forza della voce per essere ascoltato da solo. È evidente che il compito politico più importante che abbiamo davanti è quello di aiutare l’unità africana. O meglio: bisogna favorire il coordinamento progressivo e il dialogo, che aiutino l’unità dei paesi africani. Altrimenti il continente continuerà a rimanere un soggetto passivo e solo terra di confronto delle grandi potenze.
Quale proposta, la più importante, è uscita dal vostro rapporto?
Nel giro di 10 anni si dovrebbero spostare competenze e mezzi dall’Onu all’Unione africana (Ua) e alle sue strutture regionali. Il tutto, in modo empirico, cominciando da quelle realtà che sono più pronte nell’organizzazione della pace e della lotta ai conflitti tra i diversi paesi. Spostare fondi significa trasferire risorse dalle Nazioni Unite all’Ua e anche creare un fondo volontario che i paesi più ricchi dovrebbero alimentare.
La proposta ha trovato consensi?
Direi di sì, da parte dei paesi africani, dell’America Latina, della Cina, anche dell’Italia. Francia e Inghilterra, invece, si sono dette contrarie. È ovvio: c’è un comprensibile peso storico che influisce sul loro atteggiamento. Che, sotto certi aspetti, anche se non giustificato, è tuttavia comprensibile. Le loro obiezioni sono molto semplici: «Perché volete proseguire con le inefficienze? Le missioni dell’Ua hanno gli stessi difetti di quelle dell’Onu. Ne sono una copia». La mia risposta è stata semplice: «Se i militari africani non hanno un minimo di struttura di addestramento e finanziaria, se non vengono pagati, se non hanno armi, aeroporti, trasporti, reti di telecomunicazione, che cosa volete che facciano? È come se noi legassimo le gambe a un atleta e poi lo accusassimo di perdere i cento metri».
Le posizioni di Francia e Inghilterra sono significative del fatto che ancora oggi si cerca di privilegiare il rapporto bilaterale con i paesi africani.
A me sta a cuore proprio la fine di un bilateralismo ineguale. È ormai giunto il momento di affiancare ad esso un più attivo multilateralismo. Bisogna trattare l’Africa come una realtà unitaria anche nei rapporti internazionali.
Lei crede molto nel salto dall’Africa geografica all’Africa geopolitica. Ma in questi anni il continente ha fallito molte delle promesse annunciate in questo senso: i miraggi panafricani sono evaporati al calore dei conflitti. Da dove viene il suo ottimismo?
Dall’esperienza europea che, pur con tutti i suoi limiti e difetti, ha cambiato la faccia del continente. Non posso pensare che il processo africano sia più rapido di quello europeo. Sarà più lento. Ma l’idea è concreta. E partire dal peacekeeping, con i molti anni di tempo che il nostro gruppo aveva messo in conto. Questo sarebbe un obiettivo concreto e perseguibile in questo momento storico. E ancora più necessario a causa del disinteresse occidentale. I soldati europei non vanno in Africa a fare operazioni di pace, e nemmeno gli americani.
I francesi sì, però…
Solo nelle “loro” zone: in Costa d’Avorio, in Ciad, in Centrafrica. Prolungano un certo rapporto con le ex colonie. In certi casi può essere una politica utile, ma non vi è la coscienza di passare a una politica continentale. Non dico che i rapporti tradizionali vadano interrotti. Non sarebbe utile. Tuttavia, se il loro intervento non è inserito in un programma condiviso con l’Ua, non fa che perpetuare l’idea di un’Africa vista solo come terra di conquista. Invece, bisogna avere il coraggio d’introdurre, progressivamente, un nuovo schema politico che ponga l’Africa in una visione sempre più unitaria e che veda le cosiddette “grandi politiche” collaborare fra di loro nello sviluppo del continente. Si tratta di mescolare un po’ di utopia con molto realismo. E si dovrebbe rafforzare progressivamente una politica europea che sostituisca la vecchia politica bilaterale.
Oppure potrebbero essere gli stessi presidenti dei paesi della Françafrique a obbligare la Francia a perdere quel suo ruolo. Nel loro incontro di giugno, a Nizza, sono stati chiari con Sarkozy: non siamo più i tuoi schiavetti…
Ma il discorso non va impostato solo in questo modo. Si tratta di trasformare i punti di partenza e le logiche politiche. C’è un altro protagonista molto importante che non abbiamo ancora citato: gli Stati Uniti. Il presidente Obama ha fatto ragionamenti del tutto coerenti con quello che sto dicendo. Nel suo discorso al Cairo ha parlato dell’Africa come di una realtà unitaria. Inoltre, i suoi responsabili per la politica africana hanno comportamenti e mentalità del tutto nuovi. Tuttavia, non c’è ancora una decisione, una risposta ai molti interrogativi sul tavolo. Manca una spinta. Washington potrebbe essere di grande aiuto al lento passaggio dall’utopia al realismo. Perché questo è nella natura degli Stati Uniti di oggi. Che interesse ha la Casa Bianca a riassumere la sua politica africana nei rapporti con alcuni paesi petroliferi? Obama ha acceso speranze che non possono essere deluse. Ma siamo ancora in attesa di gesti che dimostrino che i suoi discorsi si trasformano in azioni.
Anche se, in verità, gli Usa si stanno muovendo in Africa: la presenza di Africom, la lotta al terrorismo nella zona sahelo-sahariana e del Corno, l’attenzione per i paesi del Golfo di Guinea per quanto riguarda le risorse energetiche…
Ma non fanno ancora una politica globale. Di investimento civile, strategico. Si capisce, certo, l’attenzione per i nuovi fenomeni del terrorismo nell’area subsahariana. Ma la politica statunitense non è tale da far muovere l’Africa in modo unitario e da portare simpatie a Washington nel lungo periodo. Se quella americana può essere considerata una politica necessaria, non è certo sufficiente. Guardate quello che sta facendo la Cina. È l’unica che sta portando avanti una politica, di fatto continentale, in Africa: sono così estesi e ramificati i suoi rapporti bilaterali che, alla fine, si sono trasformati in una politica multilaterale.
Lei ha sempre schivato tutte le critiche sul rapporto malato tra Cina e Africa.
Ma quale è stato il nostro comportamento nel continente? Ma perché devo essere fariseo? Noi europei siamo forse andati là a benedire gli africani e a difendere i diritti umani? Analizziamo caso per caso. Cominciando dai Grandi Laghi, spostandoci a sinistra, a sud e a nord. Ne ho discusso anche con diversi leader africani. E mi dicono: «Ma che differenze ci sono? Certo, i cinesi non ci chiedono condivisioni nel campo dei diritti, ma non alimentano neppure i conflitti interni, come avete sempre fatto voi europei».
Tuttavia, la non ingerenza cinese nelle vicende interne dei paesi si rivela una sponda d’oro per quella classe dirigente africana che se ne fa un baffo delle regole democratiche e che si perpetua all’infinito.
Pechino è una sponda per tutti. Non solo per i dittatori. Però, alla fine, i cinesi consegnano le strade, gli ospedali, la tecnologia, anche strutture spettacolari come gli stadi. Un giorno parlai con Bouteflika, il presidente algerino. L’Algeria non è un paese particolarmente “cinesizzato”. Mi diceva che doveva fare delle case popolari per giovani privi di redditi elevati. Fatto il bando, i cinesi hanno presentato prezzi che erano la metà di quelli offerti dagli italiani, dai francesi e da altri concorrenti. Sono venuti in 19mila e hanno consegnato le case con la puntualità di un orologio svizzero. E ogni anno qualche migliaio di cinesi si stabilizza in Algeria, si sposa in Algeria e contribuisce a costruire una classe di piccoli operatori economici che è certamente utile al paese. Ecco come cambia il continente. Sarebbe molto interessante misurare quanto è stato importante, in questi anni di crisi, l’importazione di materie prime da parte della Cina. Essa ha evitato il tracollo economico di molti paesi. Inoltre, se si analizzano i flussi commerciali dall’Africa alla Cina e dall’Africa agli Usa, hanno le stesse caratteristiche. In entrambi i casi si tratta soprattutto di materie prime e prodotti energetici. La differenza sta forse nel fatto che la Cina, esportando molti prodotti industriali, rende più difficile il decollo africano. È per questo che mi appassiono all’idea che l’Africa costruisca mercati più vasti. Quando si hanno paesi piccoli come il Rwanda o la stessa Algeria, come si fa a creare un’industria nazionale efficiente? Senza trascurare un altro fatto.
Quale?
La Cina è l’unico paese al mondo che esporta tecnologia, uomini e capitali assieme. Non è mai successo prima. Certo, ci sono alcuni luoghi di lavoro gestiti dai cinesi, come le miniere, dove vigono condizioni di lavoro molto umilianti. Ditemi, però, la differenza con quello che accadeva nelle miniere d’oro del Transvaal o in Congo Belga.
Intravede uno sbocco alla politica di Pechino in Africa?
L’ho ribadito anche in alcuni convegni tenuti in Cina: è compito morale di Pechino, e credo anche suo interesse politico, cooperare con l’Europa e con gli Stati Uniti nella politica africana. La concorrenza tra grandi potenze nel continente non può che essere tragica per l’Africa. Ma qui deve intervenire l’Ua – se volete, con tutte le sue debolezze – per aiutare questo processo, affinché l’Africa sia vista come un unico continente.
A suo avviso, ci sono paesi africani sui quali fare maggiormente leva per innescare traiettorie di sviluppo?
Nell’Africa nera, come dimensione, ci potrebbe essere solo la Nigeria. Ma è un paese talmente diviso e attraversato da scontri interni che si esclude da solo. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. Ci sono novità positive che arrivano dall’Africa: diminuiscono i conflitti, le vittime delle guerre sono meno di 20 anni fa. Non è una grande consolazione. Ma sono segnali da registrare. Di fronte a questo, tuttavia, ci sono statistiche che mi fanno rabbrividire: al primo vento di crisi, la prima voce a essere tagliata nei bilanci dei paesi occidentali è sempre l’aiuto all’estero. Quando c’è da trovare quattro soldi per l’emergenza, perché è successa una frana o c’è un’improvvisa necessità, li si ruba alla cooperazione. Fanno tutti così, salvo i paesi nordici e il Giappone.
L’Italia è il fanalino di coda in questa classifica.
Abbiamo raggiunto il livello dell’indicibile. Siamo ormai a indice zero. In ogni paese del sud del mondo in cui vai c’è almeno una strada, una diga, una scuola che abbiamo promesso ma che non abbiamo poi mai realizzato. Sarebbe stato più dignitoso non promettere nulla.
Al convegno di Bologna lei ha lanciato un “Piano Marshall per l’Africa“. Ma se queste sono le premesse, non è tutto velleitario? Non sono state tutte vane anche le promesse del G8 e del G20?
Credo di averlo denunciato mille volte: ho partecipato a dieci G8 e non abbiamo mai mantenuto le promesse uscite da quegli incontri. Come Commissione europea, siamo stati certamente più seri. E, a onor del vero, devo anche ricordare che, come presidente del consiglio, sono stato l’unico ad aumentare le risorse per la cooperazione. Ma, in generale, non c’è sensibilità in materia. Parliamoci con molta franchezza: a questo punto vedo la concorrenza della Cina in Africa come un elemento molto utile. Anche solo per risvegliarci dal torpore.
C’è anche chi teorizza come giusta la fine degli aiuti all’Africa. L’economista Dambisa Moyo ci ha costruito un caso editoriale con il suo Dead Aid (in italiano, La carità che uccide, Rizzoli).
L’ho letto. L’autrice può aver ragione in molti esempi che propone. Ma provate voi a far progredire dei paesi quando manca l’accumulazione del capitale iniziale o quando mancano scuole, ospedali e altre strutture. Il libro mette in luce solo i difetti e le mancanze, come la diffusione della corruzione, che tutti conosciamo. Ma non riesce a cancellare la realtà: senza un aiuto economico iniziale dall’estero non vi è alcuna possibilità di sviluppo per i paesi più poveri.
Il fatto che non si voglia più spendere per la cooperazione e che ci si disinteressi del lavoro delle ong in Africa o in altri paesi poveri, significa che siamo alla fine di un ciclo che esprimeva un certo approccio ai problemi del sud del mondo o è, più semplicemente, una mancanza di sensibilità?
Entriamo nel tragico rischio delle nostre democrazie: elezioni su elezioni. Si pensa al breve periodo. Devo vincere le elezioni domani, siano esse nazionali provinciali o comunali. Non c’è alcun respiro. Si è drasticamente accorciato il tempo della democrazia. Ricordo, a questo proposito, un viaggio nel Sudafrica dell’apartheid che feci quando ero presidente dell’Iri. Incontrai il primo ministro Pieter Willem Botha. Durante il colloquio, a un certo punto, mi bloccò e mi disse: «Sono belli i consigli che mi dai. Io li accetto tutti, tranne quelli che mi fanno perdere il ruolo di primo ministro». Ed è così anche da noi. Ma la politica non può essere fatta solo di legittima difesa di interessi locali e immediati. Sarebbe una politica egoistica e priva di prospettive. Eppure, poiché il “terzo mondo” non ha alcuna forza di rappresentanza politica, viene sempre sacrificato agli interessi più forti. Se vi è una necessità improvvisa o un evento imprevisto, si tolgono soldi alla cooperazione e nessuno si ribella. I movimenti cattolici, un tempo, erano attivi su questi temi. Oggi si sono affievoliti.
Una politica di corto respiro è anche quella sull’immigrazione. Che giudizio dà della “Bossi-Fini”?
Si è rivelata contraddittoria con sé stessa, visto che sono stati poi costretti a inventarsi un sacco di sanatorie per regolarizzare gli immigrati presenti sul territorio. È stato solo un gioco di propaganda, sbagliato. Quando si fa una legge che non tiene conto della realtà, oltre a essere ingiusta, è destino che non la si applichi, perché la realtà è più forte anche della “Bossi-Fini“. Ma perché è stata fatta? E perché è stato fatto il successivo decreto Maroni? Perché hanno fruttato molto dal punto di vista elettorale, dato il dominante sentimento anti-immigratorio presente nel nostro paese. A mio avviso, sono due le priorità dell’Italia in questo campo. La prima: gestire con una politica più attiva il lavoratore migrante che arriva da noi. Abbiamo solo un’immigrazione residua e non qualificata. La seconda: valorizzare le persone, una volta che queste sono arrivate. Dunque, è necessaria un’attività scolastica inclusiva. È nell’interesse del paese, visto che queste persone rimangono e i loro figli saranno nostri concittadini. Non farlo equivarrebbe a un suicidio.
In questi anni, nei quali si è occupato attivamente del continente, che idea si è fatto della classe dirigente africana? È davvero il punto debole dell’Africa?
È come un minestrone: c’è verdura di qualità e verdura di minore qualità. Guai a generalizzare! Ci sono leader che portano fatti nuovi e c’è un costume politico disastroso, con la trasformazione, spesso, di leader democratici in dittatori. Queste cose le vedo benissimo. Ma è proprio con un colloquio, con un’apertura, con un aiuto – anche condizionante – che si può migliorare la situazione. Però non bisogna, anche in questo caso, vedere solo il bicchiere mezzo vuoto. Ad esempio, il livello qualitativo dei commissari dell’Ua non è tanto più basso di quello dei loro colleghi dell’Ue. È spesso la struttura della società che rende difficile il loro agire. Ma non può essere l’Occidente a imporre la classe dirigente africana. Ciò che possiamo fare è incoraggiare la sua evoluzione: fare in modo che le elezioni siano le più trasparenti possibile, aiutare il ruolo della stampa e la crescita della società civile.
Lei parla di non sbattere mai la porta in faccia a nessuno, di dialogare con tutti. L’anno scorso si è recato a Khartoum per un colloquio con Omar El-Bashir. Qual è la sua opinione sul presidente sudanese e sul processo referendario in corso nel sud del paese per staccarsi dal nord?
Non sono favorevole alla frammentazione degli stati. Non è mai una soluzione. Ormai, però, il processo in Sudan è in corso. La speranza è che sia il più possibile un processo democratico, decente e tollerabile.
La Corte penale internazionale dell’Aia ha condannato due volte El-Bashir per la vicenda Darfur: una prima volta per crimini di guerra e contro l’umanità; una seconda per genocidio. È necessario trattare anche con soggetti così esposti di fronte alla giustizia internazionale?
Mi ha molto colpito come quasi tutti i paesi africani siano andati a difesa del presidente sudanese. Non saranno mica tutti sotto il suo controllo? La mia idea sulla giustizia internazionale è che deve essere esercitata sul passato, ma deve guardare anche al futuro. La giustizia non può basarsi solo su un’etica astratta, perché ci sono milioni di persone che potrebbero soffrire in base a quel giudizio. Non si può dettare una sentenza senza pensare alle sue conseguenze su tanta gente.
Ci deve sempre essere, quindi, una mediazione politica?
Certo. Perché in gioco c’è la vita degli uomini. Quella degli uomini vivi. Oltre che la giustizia per i morti. Bisogna contemperare entrambe le esigenze. I tribunali internazionali, poi, si dimenticano talvolta delle particolarità dell’Africa. Esistono mediazioni tradizionali che non possono essere viste solo come un fattore folcloristico, ma di rispetto di una cultura e di una storia.
La Commissione sudafricana per la riconciliazione e la verità ne è un esempio: saremmo ancora al primo grado di processo, se ci fossimo basati sui nostri criteri di giustizia.
Appunto. Se il Sudafrica è salvo è perché c’è stata questa catarsi collettiva, questo grande salto in cui molti hanno chiuso gli occhi sulle proprie ferite per il bene complessivo.
E a chi critica la sua visione troppo economicistica, nella quale si trascura troppo l’elemento giustizia?
Scusatemi, ma non è l’economia uno dei più importanti componenti della giustizia? Come fa a esserci giustizia quando la mortalità infantile è quella che è? O quando il grado di scolarizzazione è zero? L’economia e lo sviluppo sono i pilastri della giustizia.