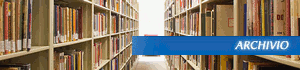L’Europa riparte solo se riscopre la solidarietà
 Prodi: «Combattere le disuguaglianze per sfuggire alla stagnazione»
Prodi: «Combattere le disuguaglianze per sfuggire alla stagnazione»
Intervista di Nicola Pini a Romano Prodi su Avvenire del 25 febbraio 2016
Riflettere sul bisogno di costruire una società più giusta. Un obiettivo al cui raggiungimento può (e deve) contribuire pure il mondo delle imprese, soprattutto quando le istituzioni democratiche mostrano una certa fatica a fornire risposte complete, adeguate, efficaci. Proprio per interrogarsi su come partecipare attivamente a una svolta necessaria, Confindustria organizza un seminario dal titolo ‘Fare insieme: etica e impresa nella società connessa e globale’. Un evento che si terrà al centro congressi Augustinianum domani – cioè alla vigilia della storica udienza di sabato 27 febbraio con le imprese di Confindustria (la prima in 106 anni di storia) che saranno ricevute da papa Francesco in Vaticano. Una platea di relatori prestigiosa. Interverranno, tra gli altri, i cardinali Domenico Calcagno, Antonio Maria Veglio e Gianfranco Ravasi, e altri relatori di prestigio.
Lanciare la sfida alle nuove, crescenti disuguaglianze. Una battaglia che ha una forte connotazione morale, ma che è anche necessaria per dare maggiore sicurezza sociale e favorire la crescita economica. L’Europa non può «perdere l’anima» e deve reagire alle previsioni di una ‘stagnazione secolare’ che, se non stiamo attenti, può diventare il nostro destino. Si può sintetizzare così il messaggio lanciato dall’ex presidente del Consiglio Romano Prodi che in questa intervista anticipa le riflessioni che svilupperà domani al convegno di Confindustria. Un appuntamento che prepara la visita degli imprenditori italiani a Papa Francesco, nell’ambito del Giubileo. Se si va avanti così «rischiamo di finire cornuti e bastonati», dice Prodi, cioè «di vivere in una società non solo ingiusta ma anche poco dinamica. Le ultime generazioni hanno rivoluzionato il mondo in un modo mai visto, ma l’insicurezza è aumentata. Non si tratta solo di timori per le tensioni politiche e la guerra. Anche a casa nostra c’è paura per il futuro delle famiglie e delle persone», afferma l’ex premier. «Una paura che frena l’economia».
Qual è l’origine di questa incertezza?
Nei Paesi sviluppati è il frutto della globalizzazione che ha coinvolto per il bene e per il male miliardi di persone, creando anche grandi insicurezze. Un fenomeno inevitabile perché con i mezzi di comunicazione di oggi il mondo è diventato più piccolo.
Diciamo allora che non c’è nulla da fare?
No, ma occorre porre rimedio ai grandi problemi causati dall’ingiusta distribuzione del reddito, dalla finanziarizzazione dall’economia e dalle nuove tecnologie.
Le diseguaglianze stanno crescendo?
Fino circa al 1980 sono diminuite, grazie all’effetto delle politiche salariali, all’azione dei sindacati, all’intervento redistributivo dei governi attraverso le imposte. Soprattutto prevaleva una dottrina economica, che possiamo definire keynesiana, per la quale la protezione sociale e l’uguaglianza erano obiettivi condivisi. Poi tutto si è rovesciato. Soprattutto per opera dei governi della Thatcher in Gran Bretagna e di Reagan negli Stati Uniti si è imposta la dottrina economica di ‘non intervento’ basata sui principi di un liberalismo esasperato. Sono diminuite in modo drastico le aliquote fiscali sui redditi maggiori, sono state abolite in molti Paesi le imposte sulle eredità e, anche se non è diminuito nel complesso il carico fiscale, è stato alleviato il peso sui redditi più elevati.
Una redistribuzione al contrario?
Sì. Ci sono state scelte politiche che hanno aumentato le differenze tra ceti alti e ceti medio-bassi. A ciò si è accompagnata la finanziarizzazione dell’economia: le strutture della finanza hanno accumulato fortune come non mai prima. Si dice che oggi un terzo delle ricchezze del mondo facciano capo a persone che starebbero tutte in un solo pullman e questo, come viene spiegato da molti economisti, perché il rendimento della finanza è più elevato del rendimento dell’economia produttiva. La tendenza liberista è diventata una prassi comune a tutti i Paesi. Compresa la Cina, che si è sviluppata a un ritmo rapidissimo ma con delle fortissime disparità. Tuttavia negli ultimi 4 o 5 anni non pochi economisti hanno cominciato a studiare il fenomeno della disuguaglianza. Pensi solo alla pubblicazione dei saggi di Piketty o di Atkinson che hanno avuto molta fortuna e hanno fortemente riorientato la ricerca, ma ancora non influenzato i comportamenti dei governi. Ancora oggi, chi parla di imposte e di riorganizzazione del sistema fiscale perde le elezioni.
Se chi punta alla ridistribuzione perde le elezioni significa che anche nel sentire comune l’idea liberista é molto diffusa.
Esatto, per questo dico che le dottrine sono importanti. Ma piano piano queste nuove analisi stanno cambiando la testa delle persone. Siamo arrivati a un fatto prima inconcepibile: un candidato alla primarie americane che si definisce socialista, parola che negli Usa era quasi un crimine di guerra. Ora è chiaro che Sanders molto probabilmente non vincerà, ma il fatto che una parte cospicua della giovane generazione americana lo sostenga è interessante perché induce a un ripensamento sui problemi di fondo.
Poco fa lei si riferiva ai rischi legati all’avvento delle nuove tecnologie.
Le nuove reti, l’economia di Internet hanno distrutto una quantità enorme di lavoro nelle classi medie. Sono sparite segretarie, impiegati, disegnatori e potremmo fare mille esempi. Sono arrivati i finanzieri pop e nelle fasce più basse le badanti e gli addetti ai call center, mentre la categoria di mezzo si è ridotta e impoverita. Anche questa è stata una forte spinta all’aumento delle disparità.
Che fare, allora?
Bisogna ripensare a questi temi. Non ne faccio solo un problema etico che pure è molto importante ma, se si vuole riagganciare la ripresa, non lo si può fare senza aumentare la propensione al consumo. Se la ricchezza si accumula solo nelle classi superiori, che consumano rispetto alle altre una percentuale minore del loro reddito, è chiaro che l’economia non si muove. E restiamo in una condizione che non dà sicurezza perché rompe la struttura sociale.
Lo sviluppo tecnologico comporterà ulteriore distruzione di lavoro?
Non c’è dubbio, questa rivoluzione tecnologica polarizza il lavoro. E il problema è serio soprattutto per Paesi come l’Italia che ha uno scarso ritmo di aumento delle professioni innovative. Se continuiamo a mandare all’estero i nostri cervelli è un suicidio collettivo. Siamo come schiacciati in una morsa, dall’alto e dal basso. Mentre gli Stati Uniti, avendo la leadership nell’innovazione, riescono a impadronirsi della parte migliore di questo cambiamento. Basti pensare che quando si sottoscrive un abbonamento a un giornale in rete, invece che su carta, il 30% va alla Apple o a chi gestisce la rete. C’è qualcosa che non va.
Poi c’è il dramma dell’immigrazione di massa, altro elemento che impaurisce.
È anche questo frutto della globalizzazione e delle disparità. Ed è un altro motivo di insicurezza. Abbiamo la guerra mondiale a pezzi, come dice il Papa. E ogni pezzo è una tragedia.
Le iniquità sono più forti ma le tensioni sociali non aumentano. Come mai?
Perché queste nuove tecnologie frammentano il mondo del lavoro. La perdita di occupazione è un fenomeno parcellizzato che rende molto più difficili le reazioni collettive. Ci sono eccezioni, come i tassisti che si ribellano a Uber, ma si tratta di una categoria circoscritta. Tuttavia se la vendita in rete fa saltare 500 piccoli negozi non succede nulla.
Il Papa stesso invita a tutelare il lavoro e a guardare a un’economia più equa.
Francesco ne parla di continuo e ha ragione. Si può fare poco a livello di singola impresa o di singolo Paese. Serve una risposta più ampia.
L’Europa saprà cambiare strada?
L’Europa può vantare a suo merito l’unica grande invenzione del secolo scorso, il welfare state ma, di fronte ai cambiamenti che ho descritto, ha progressivamente perso la sua anima. La cancelliera Merkel, che pure rischia la sua vita politica per il suo atteggiamento in favore dell’immigrazione, afferma nel contempo che l’Ue, avendo solo il 7% della popolazione e il 20% del Pil mondiale, non può sostenere il 40% del costo globale del welfare. È un discorso che ha una logica, ma 30 anni fa sarebbe stato rovesciato e saremmo partiti dalla necessità di preservare le conquiste sociali. Questa rassegnazione dell’Europa alla perdita del suo patrimonio di solidarietà mi colpisce molto. Tuttavia oggi la battaglia per una maggiore uguaglianza può essere ricominciata, perché c’è una corrente intellettuale robusta che mette in primo piano questi problemi, anche se non si è ancora trasformata in forza politica.