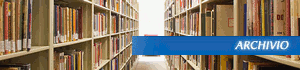Il Pd è l’unico punto di solidità del Paese. Ma con l’Ulivo l’Italia non sarebbe sprofondata in questa crisi
 La scossa di Prodi al premier: non abbia paura, ora tenti una sortita «Enrico prenda iniziative anche contestate. Io non voglio andare al Quirinale, il Paese è cambiato e non sono un uomo 2.0»
La scossa di Prodi al premier: non abbia paura, ora tenti una sortita «Enrico prenda iniziative anche contestate. Io non voglio andare al Quirinale, il Paese è cambiato e non sono un uomo 2.0»
Intervista di Aldo Cazzullo a Romano Prodi sul Corriere della Sera del 2 febbraio 2014
BOLOGNA – Professor Prodi, l’Italia vive uno dei momenti peggiori del dopoguerra. E il sogno europeo appare infranto, con la Germania che vuole farla da padrone.
«Non è che vuole: la Germania la fa da padrone. E continua per la sua strada, anche se molti osservatori, tedeschi e non tedeschi, pensano che l’eccessivo surplus renda il rapporto di cambio dell’euro insopportabile per gli altri Paesi. Un surplus minore aiuterebbe l’economia di tutta l’Europa».
L’euro è troppo forte per noi?
«Oggi siamo quasi a 1,40 sul dollaro. Fossimo a 1,10, anche 1,20, saremmo in una situazione ben diversa».
L’euro era stato pensato per valere un dollaro?
«Più o meno. Ricordo, quand’ero presidente della Commissione europea, gli incontri annuali con il presidente cinese Jiang Zemin. Avevamo dossier alti una spanna, ma a lui interessava solo l’euro. Gli consigliai di comprarne come riserva. All’inizio il valore dell’euro crollò a 0,89 rispetto al dollaro e, quando tornai da Jiang, avevo la coda fra le gambe. Ma lui mi rasserenò subito: “Lei pensa di avermi dato un cattivo consiglio, ma io continuerò a investire in euro. Perché l’euro salirà. E perché non mi piace un mondo con un solo padrone: sono felice che accanto al dollaro ci sia un’altra moneta”. A causa degli errori europei, l’altra moneta accanto al dollaro sta diventando lo yuan. Le divisioni europee ci hanno fatto perdere occasioni enormi. Vai in Medio Oriente e ti senti dire: “Siete il primo esportatore e il primo investitore, ma non contate nulla”. Non c’è un grande problema internazionale in cui l’Europa abbia contato qualcosa».
Alle elezioni del 25 maggio si profila un successo delle forze antieuropee. Può essere una scossa?
«Lo sarà senz’altro. Questa del resto è la storia d’Europa. L’Unione ha sempre avuto uno scatto dopo le crisi. La prima volta accadde con la “sedia vuota” di De Gaulle. Oggi la sensazione è ancora più forte perché abbiamo sul collo il fiato della Cina, dove fortunatamente il costo del lavoro continua a crescere. Anche se rimangono ancora grandi differenze nel costo della mano d’opera standard, oggi Unicredit paga i neolaureati di Shanghai come quelli di Milano. Dobbiamo ritrovare una politica europea comune, se vogliamo avere ancora una leadership. Occorre ribaltare la situazione. Nelle svolte del mondo bisogna essere i primi a capirle».
L’Italia si impoverisce. Eppure non c’è rivolta sociale. Perché?
«Perché la perdita del lavoro avviene goccia a goccia: infinite gocce che fanno molto più di un fiume, ma non fanno una rivoluzione. È un fenomeno mondiale: la frantumazione della classe media; la jobless society ».
La società senza lavoro.
«Si distruggono i lavori di medio livello. Disegnatori. Segretarie. Praticanti degli studi legali. Cassieri. Impiegati delle agenzie di viaggio o degli sportelli bancari e assicurativi. L’altro giorno parlavo con il responsabile di una grande banca. Gli ho chiesto se tra dieci anni i dipendenti saranno più o meno della metà rispetto a oggi. Mi ha risposto che saranno molto meno della metà. Aumenta la disoccupazione diffusa, cui si cerca rimedio con i “minijobs”: spezzoni di lavoro pagati sotto la soglia di sussistenza. Ma quando tagli la fascia media, si distanziano non soltanto i redditi; si distanziano due parti della società. Si salvano solo gli innovatori. Non a caso gli Stati Uniti, patria dell’innovazione, vanno meglio di noi».
Perché proprio l’Italia è il grande malato d’Europa?
«Perché non agisce come un Paese unito. I problemi aperti esigono una risposta corale. Invece la società è frammentata. Il governo ha una cronica mancanza di autorità. I sindacati si saltano gli uni con gli altri, sono divisi anche all’interno della stessa organizzazione, e la Confindustria è stata sempre ben contenta di dividerli. Tra sindacato e grandi imprese ci sono tensioni, come alla Fiat, che non si sono viste in nessuno stabilimento europeo. Il problema non è il costo del lavoro: in Spagna è inferiore di appena il 7%; in Germania è superiore di oltre il 50%. Il problema è il modo in cui si lavora. È la paralisi del sistema produttivo. È la mancanza di una politica industriale».
Che valutazione dà del Jobs Act di Renzi?
«La direzione è quella buona. Ma bisogna tradurla in decisioni concrete. Devono capirlo tutti: il potere politico, i sindacati, le imprese. In questi anni si sono aperti molti tavoli di concertazione; la frammentazione li ha uccisi tutti».
Voi varaste il pacchetto Treu.
«Sì, noi usavamo l’italiano e lo chiamammo pacchetto».
Oggi a Palazzo Chigi c’è un suo allievo, Enrico Letta. Quale consiglio gli darebbe?
«Di tentare una sortita. Di prendere iniziative anche contestate. Di non avere paura di mettersi in una controversia».
In un articolo sul «Messaggero» lei ha ricordato che il potere pubblico è intervenuto ovunque in difesa dell’industria dell’automobile, dalla Spagna agli Stati Uniti, tranne che in Italia.
«È oggettivo che l’affare Fiat si sia concluso senza la voce del governo. E sull’Electrolux c’è stata solo una mediazione a posteriori».
Perché è andato a votare alle primarie del Pd?
«Ho deciso il giorno dopo la sentenza della Consulta. Perché ho avuto paura che riemergesse una legge elettorale che rendesse impossibile governare il Paese».
La nuova legge le piace? Cosa pensa dell’attivismo di Renzi?
«Non rispondo a questa domanda. Ho sentito il dovere di votare alle primarie come risposta a un’emergenza, non come scelta di tornare alla partecipazione. Il ruolo elettorale è un dovere civico, non significa proporsi o essere disponibili ad accettare una carica. Ho ritenuto che il Pd fosse indispensabile per evitare lo sfascio totale. Dopo di che non ho più preso parte alla politica attiva. Sarei solo di disturbo».
Perché?
«Perché ogni azione sarebbe interpretata come appoggio all’uno o all’altro, come un disegno personale per un futuro che non esiste».
Non vuole fare il presidente della Repubblica?
«No. Mi pare di averlo già chiarito in più di un’occasione. Il Paese è cambiato. C’è un nuovo mondo. Occorrono persone nuove che lo interpretino. La nuova politica, per linguaggio, contenuto, velocità, supera la mia capacità di comprensione. Non sono un uomo 2.0».
Lei ha raccontato una telefonata con D’Alema, nel giorno dei 101 franchi tiratori, da cui dedusse che sarebbe finita male. Come andò?
«Fu anche divertente. Ero in riunione a Bamako, in Mali. C’era un’atmosfera distesa. France Presse scriveva che stavo diventando presidente della Repubblica, tutti i capi di Stato africani mi facevano il pollice alzato. Io rispondevo con il pollice verso, perché sapevo già come sarebbe andata a finire. Avevo fatto le telefonate di dovere. Prima a Marini, poi a D’Alema, che mi disse che certe candidature non si possono fare in modo così improvvisato. Fu allora che chiamai mia moglie Flavia in Italia, per dirle di andare pure alla sua riunione, tanto non sarebbe accaduto nulla. Poi telefonai a Monti, che mi avvisò che non mi avrebbe votato perché ero “divisivo”. Infine telefonai a Napolitano perché ormai era chiaro come sarebbe andata a finire. Anche se mi aspettavo 60 defezioni, non 120: perché furono più di 101».
È stato scritto che lei è in contatto con Grillo e Casaleggio. È vero?
«Mai avuto rapporti politici di nessun tipo, salvo quello di spettatore divertito. Grillo venne a trovarmi nell’81 a Nomisma, per discutere gli aspetti economici dei suoi testi. Nel 2007 mi fece un’intervista strumentale a Palazzo Chigi: all’uscita disse che dormivo. Avevo invece risposto a tutte le sue domande, spesso con gli occhi chiusi, come faccio d’abitudine quando penso, e il filmato lo dimostra. Casaleggio è venuto una volta a salutarmi a un convegno pubblico a Milano. Stop».
Come valuta il successo dei Cinque Stelle?
«È un movimento di protesta che si manifesta in varie forme in tutti i Paesi europei, tranne che in Germania. La Merkel è stata molto abile ad assorbire il populismo, riassicurando i tedeschi a scapito del resto d’Europa. Anche per questo Italia, Francia e Spagna dovrebbero reagire presentando un programma alternativo nei confronti della Germania. Noi abbiamo gli stessi interessi, ma ognuno pensa di essere più bravo degli altri. Dai consigli europei si esce con le stesse decisioni con cui si è entrati».
La sua immagine pubblica è legata alla bonomia, alla fiducia. È raro trovarla così pessimista.
«Io sono pessimista per poter essere ottimista. Il passaggio dal pessimismo all’ottimismo si ha solo attraverso un’azione politica forte e coraggiosa. L’unico fatto positivo di questa crisi drammatica è che sta maturando la consapevolezza dell’emergenza, e della necessità di cambiare. Sempre più ci si rende conto che c’è troppa gente che soffre. Finora la sofferenza arrivava alla Caritas. Ora si è affacciata persino al Forum di Davos. Anche se la finanza ha ripreso a operare come prima».
C’è il rischio di un’altra bolla e di un altro crollo?
«Non ci sono state riforme fondamentali nel sistema finanziario. C’è più paura e quindi più consapevolezza ma non ci sono veri strumenti nuovi».
Nella storia italiana recente, e quindi nel declino del Paese, anche lei ha avuto un ruolo. C’è qualche errore che non rifarebbe?
«Questa è una domanda inutile. Ci sono sfide che si affrontano sapendo perfettamente che si incontrerà la resistenza e la reazione del sistema, e quindi con buone possibilità di fallimento; eppure sono sfide che affronterei di nuovo».
Faccia un esempio.
«La privatizzazione dell’Alfa Romeo. Trattai con Ford perché ritenevo necessario che ci fosse concorrenza. Arrivammo ad un progetto di accordo di grande respiro, però avvertii i negoziatori: se si mette di mezzo la Fiat, salterà tutto, perché si muoveranno i sindacati, le autorità ecclesiastiche, gli enti locali, insomma il Paese. Fu proprio quello che accadde. È vero che la Fiat offrì qualche soldo in più ma, in ogni caso, non vi furono alternative. I negoziatori della Ford conclusero dicendo: “Ci spiace molto; lei però ci aveva detto la verità”».
Le chiedevo di farmi l’esempio di un errore.
«È un errore sopravvalutare le proprie forze. Ma penso che oggi l’Italia abbia bisogno di essere messa di fronte alle sue sfide. Per questo parlo di “sortita”. Verrà il momento in cui le sfide non si potranno non affrontare. Se hai un disegno, devi anche rischiare. E io credo di aver rischiato sempre. Non a caso, sia il primo sia il secondo governo Prodi sono stati fatti saltare. Anche se tra le due cadute c’è una bella differenza».
Quale differenza?
«Nel 2008 il mio governo è caduto a causa della frammentazione politica e dei personali interessi di alcuni suoi membri ma, in ogni caso, era un cammino faticoso. Nel 1998 il mio primo governo è caduto perché andava bene. Non solo hanno buttato giù un ottimo governo, con Ciampi all’Economia, Andreatta alla Difesa, Napolitano agli Interni, Bersani all’Industria e poi Flick e Treu… Peggio ancora: hanno distrutto l’entusiasmo. E ci vuole più di una vita per ricostruire l’entusiasmo».
Rifarebbe pure il Pd?
«Il Pd è l’unico punto di solidità del Paese. Ma se fosse andato avanti l’Ulivo avremmo avuto il Pd già quindici anni fa, e l’Italia non sarebbe sprofondata in questa crisi politica».