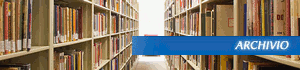Alcune riflessioni sulle evoluzioni del capitalismo dopo la crisi
 Lettera di Romano Prodi alla rivista Il Mulino, dicembre 2010.
Lettera di Romano Prodi alla rivista Il Mulino, dicembre 2010.
Caro Direttore,
mi hai gentilmente chiesto di scrivere alcune riflessioni sulle evoluzioni del capitalismo dopo la crisi e soprattutto di fare il punto su dove è finito il vecchio e appassionante dibattito della sfida fra il capitalismo anglosassone e quello germanico.
Ti confesso che una sana pigrizia mi spingeva verso il rifiuto di questa richiesta ma, dato che mi hai successivamente specificato che dovevo essere molto breve, cedo alla tua richiesta e tento di scrivere qualcosa che non sarà certo originale ma che servirà forse a qualcun altro per preparare ulteriori riflessioni. Anche perchè la tua domanda mi porta con una certa nostalgia ai dibattiti che si svolgevano in materia venti anni fa e nei quali sostenevo che, tutto sommato, il modello renano, se propriamente applicato, avrebbe garantito una crescita più regolare ed una distribuzione del reddito più equilibrata.
Per capitalismo renano si intendeva allora un sistema economico ovviamente fondato sul mercato ma nel quale le imprese non erano chiamate a rispondere solamente al mercato ma, in un certo senso, all’intera società o, almeno a quelli che venivano chiamati gli “stakeholders” e cioè non solo agli azionisti ma anche ai sindacati, ai fondi collegati all’impresa, alle comunità locali. Insomma si intendeva fondamentalmente un capitalismo più responsabile nei confronti della comunità, ovviamente con tutti i rischi connessi al fatto che tutto questo porta come conseguenza decisioni meno rapide e, non raramente, a pericolose interferenze dei poteri pubblici nella vita economica. Tutti queste complicate relazioni fra le imprese e la società circostante venivano naturalmente criticate dai sostenitori del c.d. modello anglosassone non solo per le presunte inefficienze ma anche per una vera e propria ragione di principio per cui il mercato non può essere in alcun modo influenzato, essendo in ogni caso l’unico legittimo arbitro del funzionamento del sistema economico. Le imprese sono da esso considerate normali oggetti da comprare o vendere come un qualsiasi oggetto e le interferenze del governo, dei sindacati o di qualsiasi elemento esterno nella vita delle imprese vengono liquidate come le assurde pretese di “coloro che tengono l’automobile parcheggiata in un garage e si oppongono alla vendita del garage stesso”.
Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Nel mondo ha quasi ovunque prevalso il ruolo assoluto del mercato, con un peso sempre crescente dei fondi di investimento e di vari strumenti finanziari che entrano e escono dalle imprese con una velocità vertiginosa, con un’attenzione spasmodica ai profitti di breve periodo e con un accorciamento progressivo degli orizzonti temporali, per cui anche un leggero spostamento dalle previsioni trimestrali provoca veri e propri terremoti nei comportamenti dei volatili azionisti e, quindi, nelle quotazioni delle azioni.
Le imprese sono quindi sempre più lasciate all’assoluto dominio dei mercati. Tutto questo ha provocato come logica conseguenza una generale e indiscussa opposizione ad ugni tipo di politica industriale. Il governo non deve in nessun modo mettere il naso in alcun aspetto della vita economica. La diffusione di questo vangelo è stata talmente indiscussa che è ha penetrato profondamente gli studi accademici di tutto il mondo. Sono quasi scomparsi gli studi di economia applicata per lasciare uno spazio esclusivo ad una modellistica tutta dedicata all’analisi di comportamenti astrattamente razionali.
La vita ed il mondo reale sono però ( mi viene da dire fortunatamente) molto più complicati dei modelli astratti, per cui al di sotto di questa dottrina, la realtà si è mossa spesso in modo autonomo e vari governi hanno preso decisioni vitali per riorganizzare settori in crisi, per spingere a fusioni e concentrazioni, per rafforzare strutture aziendali indebolite e, in ogni caso, per proteggere l’industria nazionale in risposta ai grandi eventi che hanno completamente rivoluzionato la vita economica mondiale.
La Francia ha messo in azione tutte le proprie risorse per creare campioni nazionali in tutti i settori in cui questo era possibile e, anche se in modo meno sistematico, ciascuno ha affrontato con tutti i mezzi possibili i problemi di casa propria. Le cose si sono molto complicate quando la globalizzazione ha portato sul mercato nuovi protagonisti, in prima battuta provenienti dalla nuova Europa e poi da tutte le parti del mondo, a cominciare dalla Cina.
E infine ci si è messa la crisi economica a mostrare come il mercato perfetto non fosse davvero tale. Dopo la crisi qualsiasi intervento dello Stato e qualsiasi azione di politica industriale sono state praticamente legittimate. Il mercato è stato messo sotto accusa prima di tutto per i suoi eccessi e per la sua mancanza di etica ma anche, in modo più profondo, per la sua incapacità di prevedere gli squilibri che hanno portato alla crisi, rendendo impossibile qualsiasi intervento correttivo. In complesso un bel disastro dal quale non sappiamo ancora come saltare fuori.
In quest’ultima fase ogni intervento pubblico è stato legittimato in nome dell’interesse nazionale e della difesa dell’occupazione. Perfino negli Stati Uniti il pesante intervento di Obama a difesa del settore dell’automobile, pur essendo stato sottoposto a notevoli critiche, è oggi riconosciuto come uno dei casi di successo della politica economica dell’amministrazione democratica.
A questo punto, caro direttore, ti aspetterai che io cominci di nuovo a elencare le virtù del capitalismo renano, a dire che in fondo avevo ragione a difenderlo , così come avevo ragione a ritenere che una politica industriale sia necessaria non solo per uscire dalla crisi ma anche e soprattutto per resistere di fronte a paesi come la Cina che suonano la musica della politica industriale con tutti i tasti che hanno a diposizione. Non nego di auspicare ( per una serie di motivi che toccano sia l’aspetto del’efficienza che quello dell’equità) un’evoluzione di questo tipo ma non mi sento di proporla perché, negli ultimi vent’anni, il mondo è così cambiato che, anche se ha deluso le aspettative e ci ha portato alla crisi, il capitalismo anglosassone è padrone del campo e le strutture finanziarie che ne sono il veicolo sono più forti dei governi. O, perlomeno, hanno una tale forza che sono in grado di condizionare il comportamento di qualsiasi potere pubblico.
Nessun governo è infatti può ragionevolmente pensare di isolarsi da questi anonimi, lontani ma potentissimi decisori finanziari e tutti hanno paura che essi, spostandosi, possano mettere in crisi non solo le imprese ma tutto il sistema economico di fronte a tutto il mondo. Il capitalismo anglosassone ha perso la sfida di essere il garante della stabilità e della crescita, ha innescato di nuovo una crisi tra le maggiori della storia dell’economia ma appare, almeno nelle concrete prospettive di oggi, sostanzialmente insostituibile. E questa impossibilità di sostituzione è evidente anche quando emerge, con altrettanta evidenza, che esso non è in grado di fornire al mercato i correttivi di cui ha bisogno per evitare il ripetersi di un’altra crisi. La contraddizione fra la globalizzazione dei mercati e il carattere nazionale della vigilanza e dei controlli è sotto i nostri occhi: restano quindi non rimediabili gli squilibri e i disordini che fatalmente si vengono a creare. E’ vero che si stanno cercando strumenti di intervento per porre riparo a queste debolezze del mercato ma si tratta fondamentalmente di correzioni minori, che non sembrano in grado di tranquillizzarci per il futuro.
Riflettiamo un attimo sull’andamento delle riunioni del G20, che dovrebbe essere l’organo politico nell’ambito del quale si affrontano e si riparano i grandi squilibri dell’economia mondiale. La riunione tenuta a Londra durante il momento più duro della crisi sembrava mostrare una precisa e forte volontà di riforma che si è progressivamente affievolita fino all’ultimo vertice di Seul, nel quale si è solo preso atto che le diverse posizioni erano tra di loro semplicemente inconciliabili.
I mercati continueranno quindi a funzionare quasi come prima, poco controllati e liberi di muoversi con il minor numero di regole possibili.
A questo punto abbiamo naturalmente l’obbligo di riflettere su quanto è avvenuto in Germania, ovviamente patria del capitalismo germanico. Nemmeno il sistema tedesco ha potuto chiamarsi fuori dall’evoluzione avvenuta negli ultimi venti anni. Esso si è molto omogeneizzato agli altri sistemi lasciandosi penetrare dalle evoluzioni avvenute a livello mondiale. I fondi di investimento e le banche d’affari ne hanno cambiato profondamente il comportamento. I legami privilegiati fra banca e impresa e gli intrecci e le protezioni fra le diverse strutture economiche si sono allentate rendendo molto più anglosassone la Germania. Anche i rapporti di lavoro sono evoluti verso una più accentuata flessibilità, aumentando fortemente la produttività del sistema. Queste evoluzioni si sono tuttavia prodotte conservando ( e sotto certi aspetti accentuando) la collaborazione tra imprenditori, sindacati e autorità politiche, che sono la caratteristica principale del sistema germanico. Questa collaborazione costituisce in un certo senso una strumento fondamentale per una politica industriale dedicata soprattutto alla razionale e concordata utilizzazione delle risorse umane e al loro potenziamento attraverso una preparazione scolastica e dei processi di apprendistato dedicati a questo scopo.
E’ naturalmente un poco ironico constatare che, nel momento in cui il sistema anglosassone esce vincitore nonostante la tragica crisi che ha provocato, il paese che conserva i più forti residui del sistema alternativo è quello che, tra le nazioni ad alto livello di sviluppo, meglio si comporta nel superamento della crisi. I tassi di sviluppo tedeschi sono infatti oggi molto superiori a quelli britannici, francesi e italiani e il surplus della bilancia commerciale è ormai di tipo “cinese”. Nel 2010 il tasso di crescita tedesco non è stato lontano dal 4%, mentre la Francia si è fermata all’1,5% e l’Italia di mezzo punto più sotto. E le cose non saranno molto diverse nell’anno in corso.
L’industria manifatturiera tedesca rappresenta una percentuale del PIL oltre il doppio di quella degli altri grandi paesi europei e, nonostante la globalizzazione e la concorrenza cinese, questa distanza tende ad aumentare. In poche parole la Germania sta diventando l’asse portante e il punto di riferimento di tutta l’industria europea. Se vogliamo cercare di capire come abbia raggiunto questi risultati mi sembra di potere rispondere che tutto ciò è avvenuto adottando il sistema finanziario anglosassone condito in una salsa operativa di tipo germanico nella quale governo, sindacati e imprenditori sono stati capaci di sedersi attorno ad un tavolo, regolare le modalità del lavoro, limare nell’emergenza i salari al ribasso per preparare la loro crescita nel futuro e, soprattutto, mobilitare le risorse dell’intera società tedesca verso l’obiettivo della trasformazione del sistema economico.
Insomma quando cerco di capire e di spiegare quello che è successo debbo concludere che la Germania ha scelto la via anglosassone nella finanza, ha spinto nella stessa direzione il suo sistema bancario accentuandone addirittura rischi e debolezze, ma ha fortemente conservato la germanità del suo sistema produttivo. E lo ha fatto, tra l’altro, con una continuità che è andata al di là del colore politico del governo in carica. Il grosso di queste riforme è stato messo in cantiere da Schroeder ma il successivo governo di Angela Merkel le ha perfezionate e attuate in modo sistematico, dimostrando ancora una volta quanto siano importanti gli elementi di continuità per rendere efficaci le decisioni di politica economica.
A questo punto, caro direttore, mi accorgo che invece di misurarmi nell’affascinante confronto fra i due sistemi, sono arrivato alla conclusione, banale ma concretamente valida, che il mondo, alla fine, corre alla ricerca di sistemi ibridi, nei quali si mescolano i più diversi incroci e nei quali le teorie fatalmente si inquinano proprio per conservare il loro potere di indirizzo e la loro forza operativa.
Ritengo quindi che le conclusioni qui esposte siano del tutto provvisorie perché un’altra ibridazione sta fatalmente per cominciare, quella fra questo complesso capitalismo occidentale e il crescente capitalismo cinese, che ha regole ancora diverse e che ha una capacità dirompente molto superiore a quella che aveva il capitalismo germanico. La presenza pubblica guidata da obiettivi fortemente condivisi, da una visione politica di lungo periodo e sostenuta da risorse finanziarie gigantesche sta già aprendo un nuovo confronto che caratterizzerà non solo la vita economica ma anche il dibattito intellettuale delle prossime generazioni.
Non penso, caro direttore, di entrare in questo dibattito, perchè non mancheranno in futuro le occasioni per farlo e anche perché sei stato così gentile e così intelligente da non chiedermelo. In questa sede mi limito ad augurare a me e a tutti gli abitanti del pianeta in cui viviamo che questo confronto avvenga non con le modalità dello scontro come è stato fra comunismo e capitalismo, ma con la regole del confronto e della contaminazione reciproca, come è avvenuto tra sistema germanico e sistema anglosassone. Credo che questa sia una partita ancora più interessante di quella precedente. E di esito ancora più incerto. In ogni caso, come si dice dalle mie parti, ne vedremo delle belle.
Grazie, con molta amicizia,
Romano Prodi