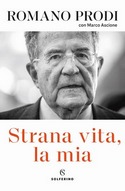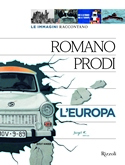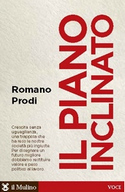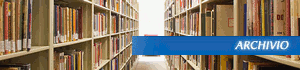Il riarmo della Germania, la difesa UE e il ruolo decisivo dell’Italia
 Segnali di guerra: la difesa UE e il ruolo decisivo dell’Italia
Segnali di guerra: la difesa UE e il ruolo decisivo dell’Italia
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 21 settembre 2025
Conseguenza immediata e inaspettata della guerra di Ucraina è stata l’improvvisa decisione, definita epocale dal cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, di aumentare fortemente la spesa militare della Germania. Aumento a cui è stato dato immediato inizio con una dotazione straordinaria di ben 100 miliardi di Euro.
Una decisione improvvisa, ma sostenuta da oltre il 70% dei tedeschi e confermata e rafforzata dall’arrivo del nuovo cancelliere, il democristiano Friedrich Merz che, quasi per sottolinearne la condivisione, ha affidato la responsabilità della difesa allo stesso ministro che la ricopriva nel precedente governo.
 Il condiviso obiettivo di fare dell’esercito federale la più potente armata tradizionale d’Europa ha cominciato ad essere messo subito in atto. Nello scorso anno le esportazioni di armi tedesche hanno superato i 13 miliardi di Euro, anche se quasi i due terzi di queste esportazioni sono stati destinati al sostegno dell’Ucraina.
Il condiviso obiettivo di fare dell’esercito federale la più potente armata tradizionale d’Europa ha cominciato ad essere messo subito in atto. Nello scorso anno le esportazioni di armi tedesche hanno superato i 13 miliardi di Euro, anche se quasi i due terzi di queste esportazioni sono stati destinati al sostegno dell’Ucraina.
Tutto questo è stato accompagnato non solo dall’abbandono dell’obbligo costituzionale del bilancio in pareggio, ma da una concreta politica di investimenti, simbolicamente ufficializzata con l’inaugurazione, in bassa Sassonia, del più grande stabilimento europeo di munizioni, costruito nel tempo record di 15 mesi dalla Rheinmetall.
 Inoltre la stessa impresa, con una politica industriale non dissimile e, per certi aspetti sostitutiva di quella del settore automobilistico oggi in crisi, ha deciso di costruire un impianto della stessa dimensione in Romania e di progettare nuovi accordi, oltre a quelli già esistenti, in Lituania e in altri paesi europei.
Inoltre la stessa impresa, con una politica industriale non dissimile e, per certi aspetti sostitutiva di quella del settore automobilistico oggi in crisi, ha deciso di costruire un impianto della stessa dimensione in Romania e di progettare nuovi accordi, oltre a quelli già esistenti, in Lituania e in altri paesi europei.
Nello stesso tempo sono iniziate le procedure per l’aumento del numero dei militari in servizio, in una fase iniziale fondato sull’ingresso di nuovi volontari, ma con la prospettiva di passare alla leva obbligatoria se non si potrà raggiungere la cifra aggiuntiva di 80.000 nuove reclute.
 Una strategia ribadita senza mezzi termini proprio quattro giorni fa da Friedrich Merz quando ha affermato che “la Germania è tornata ad essere una potenza che plasma l’Europa e non un paese che si astiene.”
Una strategia ribadita senza mezzi termini proprio quattro giorni fa da Friedrich Merz quando ha affermato che “la Germania è tornata ad essere una potenza che plasma l’Europa e non un paese che si astiene.”
Facendo i conti delle decisioni prese e dei futuri impegni di spesa, il bilancio della difesa tedesca non solo sarà il primo in Europa, ma ammonterà ad almeno il doppio dei quello francese.
Si tratta di un cambiamento di grande portata in un’Unione Europea nella quale, dopo la Brexit, la Francia ha esercitato un ruolo di assoluta primazia nella difesa e nella politica estera, mentre la Germania ha mantenuto il ruolo di leadership nell’economia.
 Come conseguenza di questi radicali cambiamenti diventa indispensabile rafforzare la collaborazione fra Francia e Germania con una strategia comune costruita, come è avvenuto nei migliori momenti di progresso del progetto europeo, con il partecipato sostegno degli altri paesi membri, a partire dall’Italia.
Come conseguenza di questi radicali cambiamenti diventa indispensabile rafforzare la collaborazione fra Francia e Germania con una strategia comune costruita, come è avvenuto nei migliori momenti di progresso del progetto europeo, con il partecipato sostegno degli altri paesi membri, a partire dall’Italia.
Non intendo con questo risvegliare vecchi fantasmi, perché i collaudati equilibri e il ruolo prevalente del parlamento rendono la democrazia tedesca una realtà esemplare, nonostante le forti divaricazioni verso l’estrema destra e l’estrema sinistra.
 Dobbiamo semplicemente prendere atto che gli squilibri che in futuro si creeranno fra Berlino e Parigi debbono essere affrontati in anticipo partendo dalla moltiplicazione delle cooperazioni fra le imprese dei diversi paesi, con programmi concordati per tipologia di armamento. Senza una politica di totale collaborazione gli aumenti quantitativi di spesa recentemente deliberati in sede Nato da tutti i membri europei ma non coordinati sul piano qualitativo, si tradurranno semplicemente in un aggravio di bilancio delle singole nazioni. Tutto questo accompagnato da parallele diminuzioni delle spese in altri settori, a partire dal welfare e con una particolare accentuazione per quanto riguarda la sanità e l’istruzione e con un vantaggio assai limitato nei confronti dello sviluppo dell’industria e della tecnologia.
Dobbiamo semplicemente prendere atto che gli squilibri che in futuro si creeranno fra Berlino e Parigi debbono essere affrontati in anticipo partendo dalla moltiplicazione delle cooperazioni fra le imprese dei diversi paesi, con programmi concordati per tipologia di armamento. Senza una politica di totale collaborazione gli aumenti quantitativi di spesa recentemente deliberati in sede Nato da tutti i membri europei ma non coordinati sul piano qualitativo, si tradurranno semplicemente in un aggravio di bilancio delle singole nazioni. Tutto questo accompagnato da parallele diminuzioni delle spese in altri settori, a partire dal welfare e con una particolare accentuazione per quanto riguarda la sanità e l’istruzione e con un vantaggio assai limitato nei confronti dello sviluppo dell’industria e della tecnologia.
 E’ inoltre doveroso aggiungere che, se non si vogliono tagliare le spese sociali, i pesanti aumenti dei bilanci della difesa dovranno essere affrontati o con un aumento delle imposte o dell’indebitamento. Non occorre spendere parole su quanto sia politicamente impossibile pensare a corposi aggravi fiscali e come sia ristretto lo spazio per un sostanziale aumento dell’indebitamento. Più della metà dei 23 paesi dell’Unione Europea che sono nello stesso tempo membri della Nato superano infatti il tetto del 60% nel rapporto fa debito e PIL e, sempre per continuare il ragionamento precedente, la Germania si trova in condizioni molto più solide nei confronti della Francia. In questo quadro così pieno di squilibri si inserisce l’ulteriore problema che solo la Francia è in possesso dell’arma politica del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza e della forza militare derivante dal possesso dell’arma atomica.
E’ inoltre doveroso aggiungere che, se non si vogliono tagliare le spese sociali, i pesanti aumenti dei bilanci della difesa dovranno essere affrontati o con un aumento delle imposte o dell’indebitamento. Non occorre spendere parole su quanto sia politicamente impossibile pensare a corposi aggravi fiscali e come sia ristretto lo spazio per un sostanziale aumento dell’indebitamento. Più della metà dei 23 paesi dell’Unione Europea che sono nello stesso tempo membri della Nato superano infatti il tetto del 60% nel rapporto fa debito e PIL e, sempre per continuare il ragionamento precedente, la Germania si trova in condizioni molto più solide nei confronti della Francia. In questo quadro così pieno di squilibri si inserisce l’ulteriore problema che solo la Francia è in possesso dell’arma politica del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza e della forza militare derivante dal possesso dell’arma atomica.
 La Francia difende da sempre e con forza il principio che il nucleare non si divide, ma le evoluzioni nelle spese militari di cui abbiamo preso nota mettono in evidenza i limiti di un sistema di difesa comune nel quale uno dei due paesi paga e l’altro comanda.
La Francia difende da sempre e con forza il principio che il nucleare non si divide, ma le evoluzioni nelle spese militari di cui abbiamo preso nota mettono in evidenza i limiti di un sistema di difesa comune nel quale uno dei due paesi paga e l’altro comanda.
Nella storia del’Unione Europea, anche quando erano in gioco differenze di interessi fra Francia e Germania, come nelle maggiori trattative commerciali, nella costruzione dell’Euro e nell’ammissione di nuovi membri, si è sempre raggiunto un faticoso compromesso, favorito da un’attiva mediazione degli altri paesi. In questo ruolo è sempre stata determinante la mediazione da parte dell’Italia, sempre in prima linea nel favorire il processo della necessaria coesione. Mi auguro che questa rilevante funzione del nostro paese sia mantenuto anche in queste così difficili circostanze.