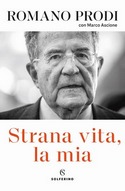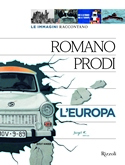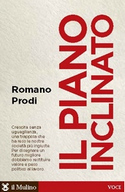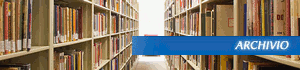La passività, nemico della speranza: mai delegare il futuro ad altri
 La passività, il nemico della speranza
La passività, il nemico della speranza
Mai delegare ad altri il nostro futuro
Questa virtù teologale non è un “detto popolare” e non è utopia: è un impegno attivo, efficace antidoto a una società autoritaria
Nel Dopoguerra abbiamo espresso volontà di rinascita Abbiamo sperato nella pace Oggi dobbiamo credere in un’Europa strumento per garantire i diritti di fronte alle grandi potenze
Articolo di Romano Prodi su Avvenire del 16 novembre 2025
Poche parole sono vittime dei detti popolari come la parola speranza. Da “spes ultima dea” per passare a “finché c’è vita c’è speranza,” arrivando al più irridente “chi vive sperando muore cantando.” Sono infiniti i detti popolari che, propriamente o impropriamente, si richiamano alla speranza come riferimento fondamentale della vita.
La speranza è istintivamente intesa come la stella polare del nostro cammino quando abbiamo perduto la strada o siamo in pericolo di perderla.
 Questa virtù teologale diventa un richiamo più insistente, quasi quotidiano, quando la nostra vita individuale o collettiva sembra entrare nell’inferno della disperazione ed è proprio la fiducia nel futuro che ci aiuta a superare i momenti difficili.
Questa virtù teologale diventa un richiamo più insistente, quasi quotidiano, quando la nostra vita individuale o collettiva sembra entrare nell’inferno della disperazione ed è proprio la fiducia nel futuro che ci aiuta a superare i momenti difficili.
La speranza ci spinge a pensare al futuro e ad operare pensando al futuro, ma con la convinzione che, nel piccolo o nel grande, il nostro atteggiamento positivo ci aiuti concretamente a prepararlo.
Non si tratta quindi di un sentimento passivo nell’attesa che le cose avvengano senza che si possa fare nulla, sia individualmente che collettivamente.
Il peggiore nemico della speranza non è quindi la disperazione, ma è la passività di fronte a quanto avviene in noi e intorno a noi.
 È proprio la perdita di speranza che ci rende passivi, spingendoci fino ad astenerci dal primo dovere di ogni cittadino, che è quello di partecipare con il voto alla costruzione di una società che noi pensiamo possa essere migliore. Con un comportamento che, se spinto fino all’esasperazione, porta fatalmente verso una società autoritaria. La perdita di speranza ci spinge infatti a delegare ad altri il nostro futuro.
È proprio la perdita di speranza che ci rende passivi, spingendoci fino ad astenerci dal primo dovere di ogni cittadino, che è quello di partecipare con il voto alla costruzione di una società che noi pensiamo possa essere migliore. Con un comportamento che, se spinto fino all’esasperazione, porta fatalmente verso una società autoritaria. La perdita di speranza ci spinge infatti a delegare ad altri il nostro futuro.
Questo è il pericolo maggiore della società in cui oggi viviamo ed è la conseguenza di una politica che preferisce scegliere l’oggi senza pensare al domani. Non si tratta di un cambiamento improvviso, ma di un cedimento progressivo in cui la rassegnazione e l’adattamento prendono il posto che dovrebbe essere proprio della volontà di progettare e costruire pensando al futuro.
Non intendo con questo confondere la speranza con l’utopia perché nella nostra storia, anche recente, abbiamo avuto momenti in cui abbiamo davvero condiviso una prospettiva proiettata verso il futuro.
Mi riferisco alla volontà di rinascita che la società italiana ha mostrato nel dopoguerra. Non solo nella ricostruzione materiale, ma nel momento in cui la speranza è stata fatta propria dalle istituzioni che, con un sincero sostegno popolare, ci hanno dato una Costituzione in cui la speranza di un futuro migliore diventava un patrimonio collettivo.
 Così come costituivano momenti di luce gli sforzi dedicati a preparare un mondo di solidarietà contando sull’istituzione e sul rafforzamento dell’Onu. Ed, in seguito, abbiamo sperato nella Pace con le ripetute conferenze sul disarmo. E la nostra fiducia si è rafforzata con la caduta del Muro di Berlino, simbolo di un passato che non doveva più ripetersi e che sembrava offrire un esempio per il futuro, accogliendo in una comunità di uguali molti paesi che prima erano stati privato della loro libertà e del loro futuro.
Così come costituivano momenti di luce gli sforzi dedicati a preparare un mondo di solidarietà contando sull’istituzione e sul rafforzamento dell’Onu. Ed, in seguito, abbiamo sperato nella Pace con le ripetute conferenze sul disarmo. E la nostra fiducia si è rafforzata con la caduta del Muro di Berlino, simbolo di un passato che non doveva più ripetersi e che sembrava offrire un esempio per il futuro, accogliendo in una comunità di uguali molti paesi che prima erano stati privato della loro libertà e del loro futuro.
Quest’elenco ci mostra però che le speranze possono affievolirsi e poi scomparire se non sono coltivate e rinnovate nel tempo. Non esiste infatti speranza senza perseveranza. Vi sono, al contrario, speranze costruite sull’illusione, come è avvenuto in alcuni momenti della nostra storia nei quali, dopo la generazione del dopoguerra, è stato promesso un futuro migliore a tutti senza però tenere conto delle energie e delle risorse necessarie per prepararlo e senza fare presente all’intera comunità i sacrifici che dovevano essere compiuti. Il futuro non si costruisce promettendo la perfezione, ma dicendo la verità.
 La speranza deve guardare al cielo ma deve avere i piedi ben piantati a terra, nell’impegno individuale e, soprattutto, nella capacità di creare la solidarietà necessaria per farla diventare un obiettivo condiviso. Quando negli anni ottanta si è pensato di accendere una speranza collettiva promettendo tutto a tutti, ma non mettendo sul tavolo le condizioni perché questo avvenisse, si sono poste solo le condizioni per creare sfiducia. Con queste speranze illusorie abbiamo distrutto la capacità di interpretare il nostro futuro.
La speranza deve guardare al cielo ma deve avere i piedi ben piantati a terra, nell’impegno individuale e, soprattutto, nella capacità di creare la solidarietà necessaria per farla diventare un obiettivo condiviso. Quando negli anni ottanta si è pensato di accendere una speranza collettiva promettendo tutto a tutti, ma non mettendo sul tavolo le condizioni perché questo avvenisse, si sono poste solo le condizioni per creare sfiducia. Con queste speranze illusorie abbiamo distrutto la capacità di interpretare il nostro futuro.
Una capacità che oggi dobbiamo riprendere ponendoci obiettivi condivisi in grado di mobilitare le nostre energie individuali e collettive.
In primo luogo dobbiamo porci un obiettivo politico che ci permetta di giocare un ruolo positivo nel grande processo di trasformazione a cui oggi stiamo assistendo in modo passivo, rassegnati a giocare come comparse nella storia futura.
 Dobbiamo quindi credere nell’Europa come possibile strumento per garantire i diritti individuali e collettivi di fronte alle grandi potenze che dominano il pianeta con un autoritarismo che rispetta solo la forza. Si tratta di impegnarsi nel sostegno della dignità delle persone, della loro capacità di unirsi in uno sforzo comune in difesa dei diritti e della legalità, con la speranza che il bene possa fiorire anche nelle circostanze avverse e che, operando insieme, si possano prendere decisioni economiche e politiche in grado di preparare un mondo migliore. Tenendo sempre i piedi ben piantati sulla terra, dobbiamo tenere presente che non si può costruire una speranza collettiva se non si ha il coraggio di abbandonare i nazionalismi del passato e di operare per dare vita a una solidarietà in grado di rendere patrimonio comune i progressi compiuti nei rapporti di cooperazione fra paesi che si erano combattuti per secoli.
Dobbiamo quindi credere nell’Europa come possibile strumento per garantire i diritti individuali e collettivi di fronte alle grandi potenze che dominano il pianeta con un autoritarismo che rispetta solo la forza. Si tratta di impegnarsi nel sostegno della dignità delle persone, della loro capacità di unirsi in uno sforzo comune in difesa dei diritti e della legalità, con la speranza che il bene possa fiorire anche nelle circostanze avverse e che, operando insieme, si possano prendere decisioni economiche e politiche in grado di preparare un mondo migliore. Tenendo sempre i piedi ben piantati sulla terra, dobbiamo tenere presente che non si può costruire una speranza collettiva se non si ha il coraggio di abbandonare i nazionalismi del passato e di operare per dare vita a una solidarietà in grado di rendere patrimonio comune i progressi compiuti nei rapporti di cooperazione fra paesi che si erano combattuti per secoli.
Una solidarietà che sembra essere messa a dura prova dai progressi senza precedenti che stanno trasformando le radici stessa della nostra società. Non solo del nostro modo di lavorare, ma dello modo stesso di pensare e di metterci in rapporto con gli altri.
 Oggi si parla soprattutto dell’intelligenza artificiale ma tutto il mondo della conoscenza sembra spingere verso una concentrazione della ricchezza e un aumento della differenza nell’esercizio del potere e del possesso delle risorse economiche. Verso una società nella quale la voce della solidarietà viene messa a tacere da un élite che, abusando del possesso della conoscenza, aumenta il potere del denaro e il suo dominio sulla società. Non vi può essere speranza quando una parte crescente della popolazione vive o teme di vivere nella disperazione e le nuove tecnologie si dirigono soprattutto verso i paesi che già godono di condizioni privilegiate. La speranza di una migliore distribuzione del sapere e della ricchezza non può essere considerata un’utopia, ma un processo che, se pure in modo minore rispetto alle aspettative, si è tuttavia verificato nello spazio di tempo tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni ottanta del secolo scorso. Un periodo in cui non dominava un liberismo assoluto e la dinamica fra le forze sociali faceva pensare a un crescente, anche se lento, aumento della giustizia sociale. E quindi a una speranza più diffusa.
Oggi si parla soprattutto dell’intelligenza artificiale ma tutto il mondo della conoscenza sembra spingere verso una concentrazione della ricchezza e un aumento della differenza nell’esercizio del potere e del possesso delle risorse economiche. Verso una società nella quale la voce della solidarietà viene messa a tacere da un élite che, abusando del possesso della conoscenza, aumenta il potere del denaro e il suo dominio sulla società. Non vi può essere speranza quando una parte crescente della popolazione vive o teme di vivere nella disperazione e le nuove tecnologie si dirigono soprattutto verso i paesi che già godono di condizioni privilegiate. La speranza di una migliore distribuzione del sapere e della ricchezza non può essere considerata un’utopia, ma un processo che, se pure in modo minore rispetto alle aspettative, si è tuttavia verificato nello spazio di tempo tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni ottanta del secolo scorso. Un periodo in cui non dominava un liberismo assoluto e la dinamica fra le forze sociali faceva pensare a un crescente, anche se lento, aumento della giustizia sociale. E quindi a una speranza più diffusa.
 Dato che non sono un teologo ho parlato più della speranza terrena che non di quella celeste. Credo però che le due speranze si aiutino a vicenda: entrambe si nutrono di pace, giustizia e solidarietà. La speranza terrena e la speranza celeste si sostengono reciprocamente nel momento della prova e nelle difficoltà che nascono dalla crisi e dalla paura. Operano insieme perché entrambe si fondano sul senso della vita e sull’obbligo della generosità.
Dato che non sono un teologo ho parlato più della speranza terrena che non di quella celeste. Credo però che le due speranze si aiutino a vicenda: entrambe si nutrono di pace, giustizia e solidarietà. La speranza terrena e la speranza celeste si sostengono reciprocamente nel momento della prova e nelle difficoltà che nascono dalla crisi e dalla paura. Operano insieme perché entrambe si fondano sul senso della vita e sull’obbligo della generosità.
La speranza è una forza silenziosa che modifica il modo di affrontare la vita in ogni suo aspetto. Non dimentichiamo però che, nel precetto evangelico, la speranza è solo una delle tre virtù teologali e non può vivere separata dalla fede e dalla carità. Non dimentichiamo, soprattutto, che non vi è speranza senza la carità. Un monito che va bene sia per i responsabili della politica che per i predicatori del vangelo.